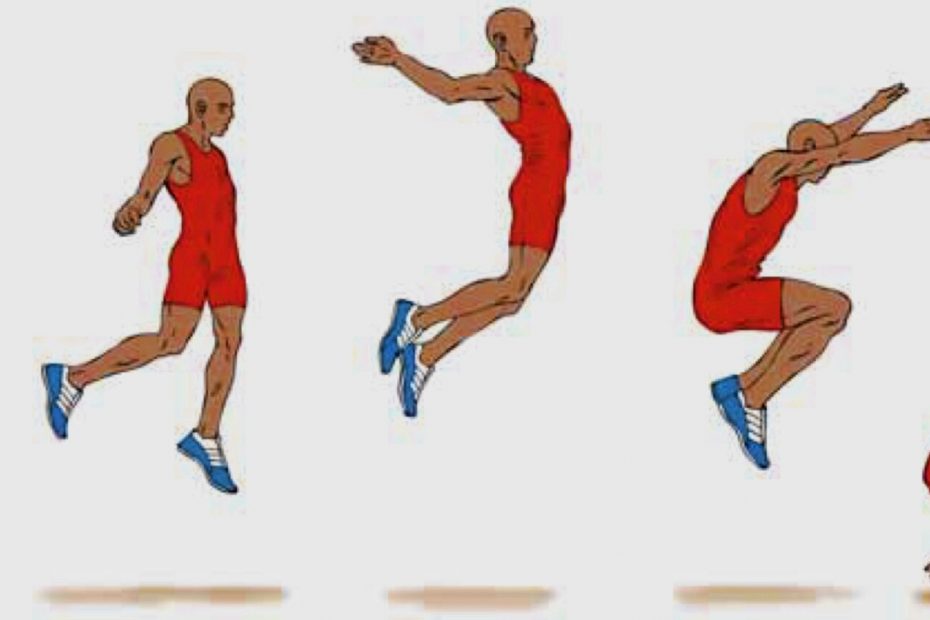Franco Nanni
Maggio 2021: “I ragazzi sono stremati, dicono che se hanno tutte queste verifiche, cosa imparano? Niente, perché non hanno neanche il tempo di fissare le cose. La tensione cresce finché il più bravo della classe urla tremante: “Questa non è scuola, io così non posso andare avanti”. Così racconta una docente di scuola superiore, ripresa poi da un blogger su quotidiano nazionale. Coincide, quasi letteralmente, col grido che raccolgo dagli adolescenti che incontro nel mio lavoro. Il ritorno in presenza ha esacerbato una tendenza non certo nuova: le scuole superiori (quantomeno i licei e i tecnici) sono divenute luoghi di pena: ansia da prestazione, inadeguatezza, angoscia di non farcela, insonnia… e i docenti chiedono sempre di più.
La situazione attuale dovrebbe stimolarci domande più generali: perché la scuola dell’obbligo arranca nella sua missione di creare un terreno culturale di base comune a tutti? E perché, una volta giunti alle superiori, troppi studenti si trovano a scontare tante difficoltà? Perché, a dispetto di ciò, in queste scuole si aumenta la pressione alla prestazione?
Una psicologia critica dello sviluppo
Molti anni fa W. Battacchi (Per una psicologia critica dello sviluppo, Psicologia Contemporanea n.197, 2006) ci avvertiva profeticamente di trasformazioni nella normalità statistica degli individui, che si stava spostando in direzione di un feroce narcisismo e di una “normale indifferenza” verso i deboli e la sofferenza. Oggi altri spostamenti sono in atto, e riguardano crescenti difficoltà in diverse aree: sviluppo del linguaggio e del lessico, capacità di orientare e sostenere l’attenzione nonché di ordinare nel tempo e in modo logico una sequenza di fatti, carenze nell’insieme delle funzioni della memoria a breve termine, nonché nella autoregolazione degli impulsi e delle emozioni. Non dovremmo quindi stupirci che stia crescendo il numero di bambini che entra alla scuola elementare già con un gap delle capacità cognitive e emotive, un gap che li limiterà poi in quasi ogni ambito del percorso scolastico. Bambini sovrastimolati, un po’ disorganizzati, fisiologicamente ansiosi, poco capaci di legami e di contatti con l’altro da sé. Credo che la scuola non possa più fingere che si tratti di “incidenti”: si tratta della (nuova) normalità. Una volta arrivati alle scuole superiori, in un ambiente proteso alla performance, questi alunni sconteranno fino in fondo le loro fragilità, stimolando famiglie e docenti a cercare risposte compensatorie, la più frequente delle quali è il ricorso a una diagnosi (assai tardiva sul piano clinico!) di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA, ovvero dislessia, disortografia, discalculia). Perché ci si butta verso questo ambito è presto detto: è una risposta assai funzionale sia per proteggersi dalle richieste eccessive che per conservare lo status quo dei miti competitivi: lo scarso rendimento trova una spiegazione compatibile con la possibilità di primeggiare altrove, senza intaccare il mito di un tipo umano ideale, compiutamente autorealizzato e sorretto da una granitica autostima e un incrollabile ottimismo, che in filigrana alimenta tanta (pseudo?)-pedagogia improntata all’autoefficacia, all’autostima e all’auto-motivazione.
La sospensione della pietà
Che cosa è dunque, nella percezione comune, la scuola superiore? Questa ricerca di risarcimenti per le angherie passate, e di un casco protettivo per gli anni a venire, fa pensare a un luogo ostile dove chiunque abbia qualche fragilità debba essere protetto, un campo di gara dove chi ha certe carenze “merita” delle compensazioni e delle dispense per poter comunque competere e arrivare al traguardo.
Tempo fa mi è stato girato un resoconto di assemblea di classe di una seconda Istituto Tecnico, aperta ai genitori, dove il solerte verbalizzatore cita letteralmente un docente: «Non avremo pietà per nessuno»; potrebbe essere una iperbole pronunciata da un docente imprudente, ma colpisce che tale affermazione venga accolta da una sorta di silenzio-assenso, in assenza di commenti o reazioni da parte degli astanti. Questo esempio, anche se naturalmente non rappresenta tutte le realtà, disegna a tinte forti una realtà ben percepibile in molti contesti della scuola superiore: essa è o dovrebbe essere un luogo dove la pietà umana è sospesa, nel consenso generalizzato, e dove, per poterne ricevere in deroga, è necessario essere dichiarati “malati”. Un mondo nuovo si spalanca davanti ai nostri occhi: ciò che abbiamo chiamato medicalizzazione è invece tutt’altro: il salvacondotto per vedersi restituita una pietà altrimenti sospesa, al costo però di vedersi affissa sulla giacca una qualche etichetta diagnostica. Come siamo arrivati fin qui?
Beati i primi
Da non meno di due decenni la nostra cultura è stata rimpinzata di concetti come competitività, eccellenza, agonismo; ogni adulto li respira ovunque, sul lavoro, sui giornali, sulle riviste del benessere, poi li passa ai figli. I genitori assumono come realtà tout court l’idea che i propri figli entreranno in un mondo ostile dove non ci sono opportunità per tutti ma solo per i primi, non importa primi in che cosa, purché primi. Autorevoli commentatori suggeriscono che i successi scolastici e le promozioni hanno valore solo se non sono per tutti: ci dev’essere una selezione darwiniana dove il meno adatto soccombe. L’importante non è partecipare ma vincere, e con qualunque mezzo.
Solo in questo scenario prospera il mito, oggi asfissiante nella prosa delle istituzioni scolastiche: inclusione. che suona più o meno come: “ci impegniamo per non perdere per strada nessun alunno e perché tutti arrivino alla meta”. Tale principio cela una implicazione non dichiarata: che sia normalmente possibile che qualcuno si perda. Ebbene, confessiamocelo: la nostra scuola si è progressivamente abituata all’idea che sia normalmente possibile perdere alunni durante il percorso, e che, anzi, ciò sia il segnale di una buona scuola, a detta di certi commentatori. Qualcuno vuole ancora stupirsi che le forze politiche cosiddette “suprematiste” intercettino in tutta Europa larghe fasce del voto giovanile? Come potrebbe essere altrimenti, visto il mondo che le generazioni precedenti hanno predisposto per i millennials? Non faranno prigionieri, e tratteranno gli altri nel modo in cui loro stessi sono stati allevati: senza pietà. Non deve stupire nemmeno che altri loro coetanei si chiudano nelle proprie stanze e non ne escano più, i cosiddetti Hikikomori, che sembrano ritenere il mondo là fuori troppo inospitale e difficile. Forse, a ben guardare, hanno visto giusto e sono dunque meno “malati” degli altri. Sì, in quanto i fautori sfegatati della competitività/competizione presentano il loro idolo come il bene supremo facendo i conti senza l’oste: questa tensione ha dei costi in termini di salute mentale che ancora non riusciamo a stimare con precisione, ma temo che il conto sarà piuttosto salato.